I tre errori su Ventotene
Lasciamo perdere la ricerca dei motivi che hanno indotto la Meloni ad aprire una polemica sul Manifesto di Ventotene e anche, se ne valutiamo i passaggi, a leggere frasi peraltro a metà e fuori dal contesto storico e politico dell’epoca (“datemi sei righe del più onesto degli uomini e gli troverò un motivo per farlo impiccare”, scrive il cardinale Richelieu). Restiamo invece al detto e al non detto. Primo errore, anzi orrore e vergogna. Questa é responsabilità di larga parte della stampa e delle televisioni a cui ha cercato di porre rimedio l’on. Fornaro, già Psdi e oggi Pd, nel suo vibrante discorso alla Camera. Si dimentica sempre del trunvirato di Ventotene la figura di Eugenio Colorni che fu invece centrale nella scrittura del testo e che ne riuscì a far pubblicare la stesura clandestinamente a Roma, dopo averla corretta e sintetizzata. Colorni era un socialista autonomista, viene proprio citato così, capo redattore dell’Avanti clandestino, un filosofo leibniziano, allievo di Croce e Gentile, che venne assassinato dalla banda Coch, famigerato raggruppamento fascista della capitale nel 1944, alla vigilia della liberazione di Roma. Sua moglie ha poi sposato Altiero Spinelli, quasi a rivendicare un legame non solo personale tra i due. Ma una sorta di eredità ideale. Vergogna, ancora una volta si oltraggia cosi la storia socialista relegandola nella soffitta delle dimenticanze. Secondo errore. La Meloni ha citato il passaggio sulla proprietà privata asserendo che il manifesto ne propone l’abolizione. Leggiamo insieme questo passaggio: “La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa non dogmaticamente, caso per caso“. E poi si elencano i casi. Clamorosamente attuale e quello dell’energia elettrica che i socialisti pretesero di nazionalizzare nel primo governo di centro-sinistra. A me pare che sul punto emerga invece un’impostazione non certo marxista e nemmeno socialdemocratica quando si propone addirittura il caso di un’estensione della proprietà privata. Ma andiamo oltre. Il passaggio polemico si riferisce alla funzione del cosiddetto Partito rivoluzionario che dovrebbe sorgere nell’immediato dopoguerra e alla sua dittatura. Poteva essere usato un altro termine, ad esempio quello gramsciano di egemonia. Ma anche qui, terzo errore, la Meloni suppone che i tre estensori progettassero una sorta di regime totalitario, in salsa sovietica. Si scrive nel terzo capitolo del testo (la riduzione da quattro a tre del Manifesto fu opera di Colorni): “Delle varie tendenze proletarie, seguaci della politica classista e dell’ideale collettivista, i comunisti hanno riconosciuto la difficoltà di ottenere un seguito di forze sufficienti per vincere, e per ciò si sono, a differenza degli altri partiti popolari, trasformati in un movimento rigidamente disciplinato, che sfrutta quel che residua del mito russo per organizzare gli operai, ma non prende leggi da essi, e li utilizza nelle più disparate manovre. Questo atteggiamento rende i comunisti, nelle crisi rivoluzionarie, più efficienti dei democratici; ma tenendo essi distinte quanto più possono le classi operaie dalle altre forze rivoluzionarie, col predicare che la loro “vera” rivoluzione è ancora da venire, costituiscono nei momenti decisivi un elemento settario che indebolisce il tutto. Inoltre la loro assidua dipendenza allo stato russo, che li ha ripetutamente adoperati senza scrupoli per il perseguimento della sua politica nazionale, impedisce loro di perseguire una politica con un minimo di continuità. Hanno sempre bisogno di nascondersi dietro un Karoly, un Blum, un Negrin, per andare poi fatalmente in rovina dietro i fantocci democratici adoperati, poiché il potere si consegue e si mantiene non semplicemente con la furberia, ma con la capacità di rispondere in modo organico e vitale alle necessità della società moderna. La loro scarsa consistenza si palesa invece senza possibilità di equivoci quando, venendo a mancare il camuffamento, fanno regolarmente mostra di un puro verbalismo estremista”. D’altronde dei tre solo Altiero Spinelli era stato comunista, ma dal Pcdi era stato espulso nel 1937 per aver condannato lo stalinismo e la dittatura, mentre Ernesto Rossi era di formazione rosselliana aderente a Giustizia e libertà. E a proposito del partito rivoluzionario che avrebbe dovuto guidare il popolo non gia verso uno stato nazionale ma verso uno stato europeo federale si aggiungeva: “Non è da temere che un tale regime rivoluzionario debba necessariamente sbocciare in un nuovo dispotismo. Vi sbocca se è venuto modellando un tipo di società servile. Ma se il partito rivoluzionario andrà creando con polso fermo fin dai primissimi passi le condizioni per una vita libera, in cui tutti i cittadini possano veramente partecipare alla vita dello stato, la sua evoluzione sarà, anche se attraverso eventuali secondarie crisi politiche, nel senso di una progressiva comprensione ed accettazione da parte di tutti del nuovo ordine, e perciò nel senso di una crescente possibilità di funzionamento di istituzioni politiche libere”. Era il 1941 e la Germania nazista stava vincendo la guerra. Erano i tre, esponenti politici tutti di impostazione liberalsocialista, votati profeticamente al futuro. E ci voleva coraggio, intelligenza, lucidità a immaginare che dopo due guerre ispirate dai nazionalismi potesse sorgere un’Europa federale. Oggi dobbiamo a quella intuizione anche i passi in avanti compiuti. Il testo conteneva anche la necessità di dotare lo stato federale di un esercito comune e l’idea, proiettata al presente, si sta trasformando in necessità. La Meloni non sappiamo quale Europa voglia. Noi sappiamo che il testo del manifesto di Ventotene compie 84 anni e risente certo del clima dell’epoca e della condizione in cui si trovavano i tre pionieri. Ma la sostanza di quel messaggio noi anche ora non solo la condividiamo ma ne riconosciamo il luminoso carattere preveggente. Lo spirito critico e l’antidogmatismo di cui il manifesto é impregnato lo facciamo nostro. E lo leggiamo senza enfasi ma con rinnovata e sorprendente ammirazione.
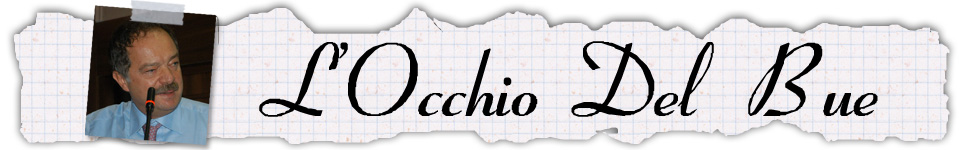







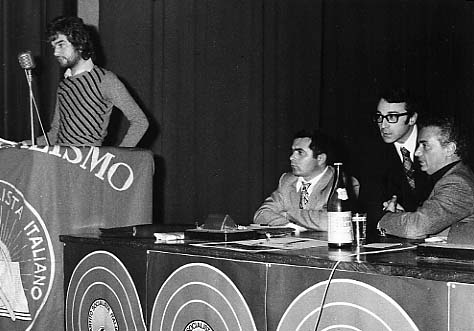
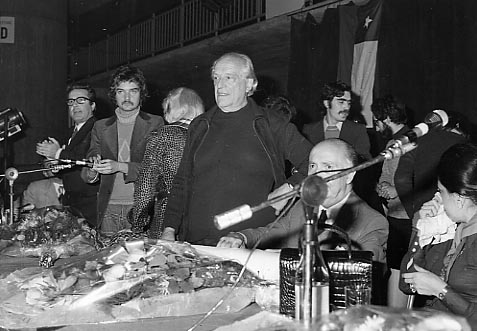

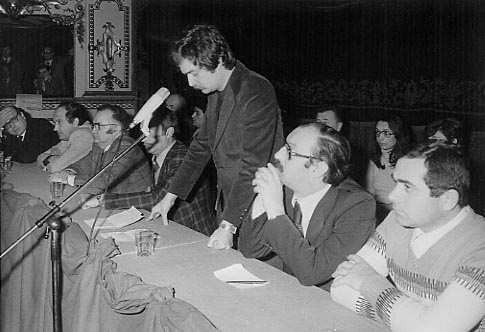


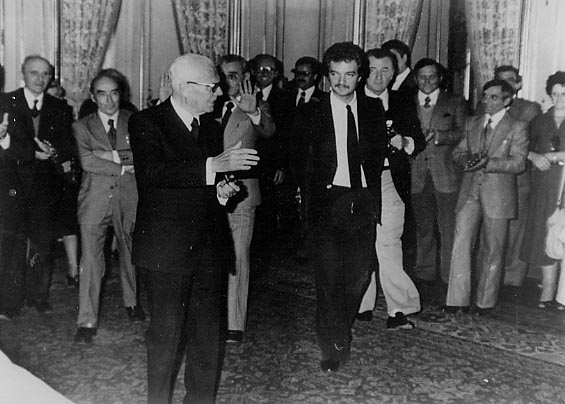
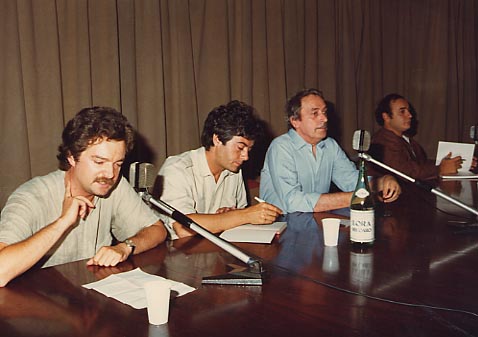
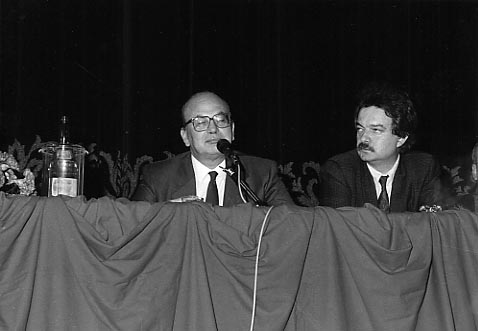




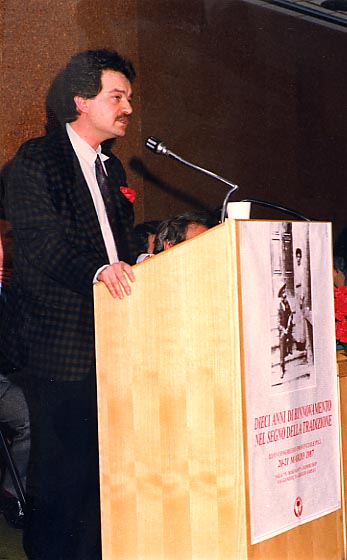
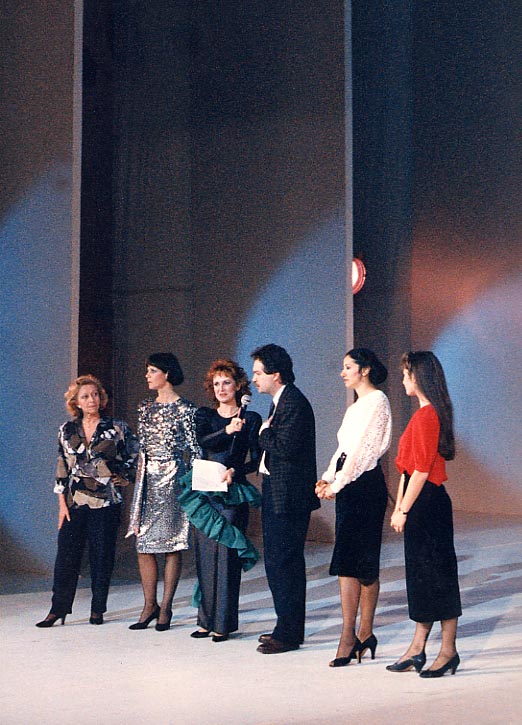
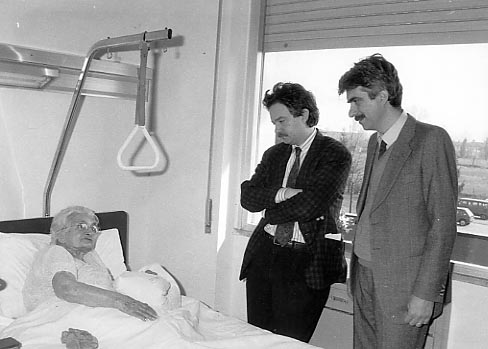











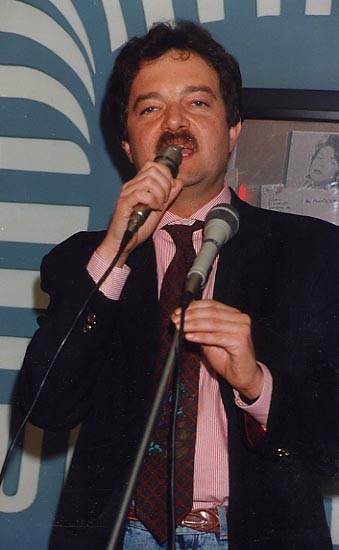

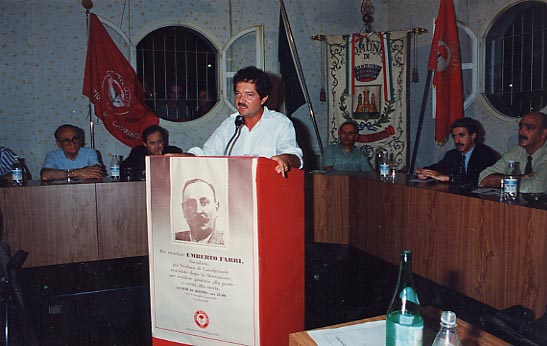











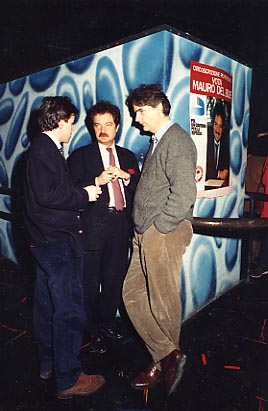






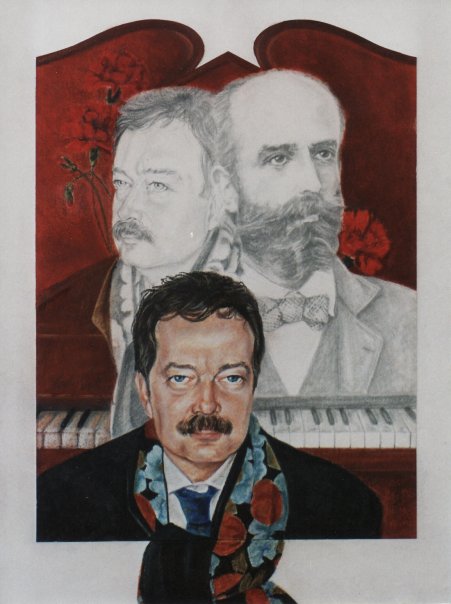




















Leave your response!