La prima alla Scala. Un Fidelio fuori dal tempo
Il maestro Baremboin ha voluto sottolineare il valore del silenzio nell’opera beethoveniana. Non il silenzio da cui nasce la musica e nel quale la musica si estingue. Ma il silenzio che si frappone alla musica, che la definisce e la esalta. Nelle sue espressioni drammatiche Baremboin questo ha voluto sottolineare nel suo Fidelio. E forse anche per questo Paolo Isotta ne ha criticato i tempi, a suo parere troppo lenti. Baremboin ha poi voluto eseguire la sinfonia di Leonora tre, quella precedente l’ultima, in mi maggiore, che Beethoven scelse come definitiva, dopo la composizione delle tre precedenti. Discutibile che sia stato giusto per Baremboin quel che non è apparso opportuno per il compositore. Eppure nelle sinfonia eseguita si anticipa la fine, quello squillo di tromba che è segnale di libertà. Il Fidelio esalta la virtù dell’amore di Leonora, che si traveste da Fidelio, e con temerarietà va alla ricerca dello sposo, internato dal tiranno Pizarro. Si tratta di una vicenda realmente accaduta sotto il terrore di Robespierre che Beethoven mette in musica come vicenda spagnola, accaduta a Siviglia. La musica del Beethoven maturo appare sempre dominata dall’aspetto tragico, solo di quando in quando frammista a concertati di stampo rossiniano, soprattuto quello del primo atto, che molto somiglia a quello della Cenerentola, ma è Rossini ad averlo desunto da Beethoven visto che il musicista tedesco ha composto l’opera tra il 1803 e il 1805. Il Fidelio è l’unica opera di Beethoven, che sempre si è misurato con le sinfonie e le sonate. Solo in Fidelio il compositore di Bonn ha voluto sposare il teatro d’opera e lo ha fatto con non poche revisioni, probabilmente anche palpiti. Certo un maestro come Baremboin, che lascia la Scala in un mare di ovazioni, e verrà sostituto da Chailly, non poteva che pensare a Beethoven per l’addio, dopo che con Beethoven aveva cominciato. Orchestra e coro mi sono apparsi invero impeccabili. Quest’ultimo, nella parte finale, in quell’insieme di esaltazione della giustizia, della libertà, della vendetta verso il tiranno, di giubilo per la donna che da persona diventa qui icona di amore e di libertà, si diffonde con sicura maestria. In fondo l’opera è Leonora, visto che Fidelio è il suo travestimento. E Leonora, interpretata da Anja Kampe, canta e recita con credibilità, anche se un tantino traballante nel registro acuto. Piu discutibile suo marito Florestan, Klaus Florian Vogt, una sorta di conte di Montecristo ingiustamente condannato al carcere più duro, in fondo, quasi all’inferno, che ha problemi nel fraseggio e nell’estensione vocale. Bene invece il Rocco del piccolo asiatico Kwangchul Youn dal tono grave e drammatico. Poi la regia e la scenografia. Nulla da dire sul rinnovamento e nemmeno sulla contemporaneità. Ma che Fidelio si presenti subito come uno spazzacamino desta un po’ di sorpresa. Anche quel concepire il carcere come una fabbrica, forse oggi quanto mai di moda, soprattutto in vista dello sciopero generale sul Jobs act, lascia fondate perplessità. Anche se produce l’effetto del coro del primo atto come il famoso dipinto di Pellizzi da Volpeda e nelle scene finali un misto di occupazione in stile sessantotto, di uscita dei minatori del Sulcis, con tanto di casco e di visiera, col buono, il ministro vestito in stile Armani, contrapposto al tiranno cattivo, vestito in abito stile Facis, che tenta una difesa, poi fugge e s’ode un disvelatore colpo di pistola. Qualche incongruenza nella trama c’è. Quel povero Florestan, che diventa anche Abate Faria, sta due anni nel pozzo della galera, non si capisce come sopravviva, nessuno gli porta da mangiare e da bere, non si lava mai (neppure i denti. Non gli fanno mai male?) poi vede Rocco e Leonora-Fidelio, chiede loro un po’ d’acqua, gli danno una bottiglietta di vino, che lui benedice come farmaco, poi si consultano i due per sapere se possono offrirgli anche un tozzo di pane. Vabbé, misteri del teatro. Soprattutto di quello in musica. Come quelle bandiere rosse che sventolano alla fine. La regista Deborah Warner ha voluto ricordare l’Ucraina e l’Isis. Chissà perché ho sempre pensato che il colore rosso avesse altra e piu nobile radice.











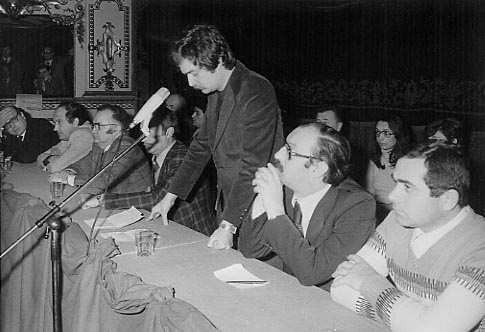

































































Leave your response!