Gli enigmi dell’Expo e di Turandot
In nome dell’Expo abbiamo dovuto sopportare Andrea Bocelli che canta “Di quella pira” con tono abbassato e fuori tempo. Va bene. La popolarità è il nuovo credo e la pubblicità impone di accettare che Andrea sia un tenore. Da non confondere con Francesco Meli, che era al suo fianco, che tenore invece, e di qualità, è certamente. Ma che, nell’epoca del trionfo dell’immagine, vestiva i panni del comprimario. Poi dobbiamo anche scrivere, come fanno tutti, che Aleksandre Antonenko, il Calaf della sontuosa Turandot dell’assurdo andata in scena ieri sera a Milano, sia all’altezza del ruolo. Difficilmente abbiamo ascoltato un “Nessun dorma” più squilibrato e senza pathos che non sia la paura, anzi il terrore, di graffiare quel si naturale prolungato. Lo si intravedeva dagli occhi più simili a quelli di Otello che uccide Desdemona che non all’espressione del principe che sfida la principessa di gelo a scongelarsi. Dobbiamo fare anche questo in nome dell’Expo? Siam pronti alla morte, anzi alla vita. E va bene. Però un critico musicale non può chiudersi le orecchie. E non sentire quanto sia sgretolata e ingolata la vocalità di un cantante. Di quanto gli riesca una sola mascheratura che esalta le sue tonsille. Pazienza. Tutto molto accattivante il resto. Cominciamo da Chailly, alla sua prima prova come direttore stabile. Niente è più difficile di Turandot dove ai soliti momenti estatici pucciniani si alternano pagine di esaltazione timbrica che non hanno eguali nello spartito del musicista di Torre del lago. Chailly riesce con successo a trovare giusta misura nel sottolineare i due ingredienti, le rasoiate di violini del primo atto che entrano d’impatto come il pentatonismo orientale che qui è molto più marcato che non in Butterflay. Anche la nuova ricerca che pare sconfinare nel musical e nel ritmo jazzato mostrano sottigliezze e colori unici. Trionfatrice della serata è la Liù di Maria Agresta, dolcissima, intonata, a tratti soave, che sprigiona amore e pietà. E si contrappone al ghiaccio della principessa, Ninna Stemme, che il regista Nikolauss Lenhoff trasforma in un ragno nero, cupo che poi si riconosce donna grazie al sacrificio di Liù e alla scoperta dell’amore. Il regista ha riattivato la scenografia già sperimentata ad Amsterdam. Il corpo di Liù, ma in realtà la sua anima, è presente fino alla fine, perchè è Liù la protagonista, il vero motore dell’opera, che la capovolge e la orienta al lieto fine. Tutto è giocato tra echi del teatro alla Ionesco e ricalchi del gioco in stile kabuki. Affascinante direi. Il colore rosso, le maschere e gli occhi cadaverici delle masse, la splendida frequente incursione dei tre ministri che donano all’opera quel fresco, assurdo, ironico smalto di fantastica presa in giro, ti prende e ti trascina verso il finale che vuoi ascoltare con attenzione. Il finale di Berio che qui si sostituisce a quello tradizionale di Alfano e che si staglia dopo la duplice morte di Liù e di Puccini. Mi chiedo sempre se ci fosse stato Toscanini, il maestro che mise le mani sullo spartito di Alfano e ne stralciò più di metà. Per rigore e rispetto di Puccini. L’intervento di Berio è suggestivo. Meno trionfale di quello di Alfano, più intimo. Forse anche più rispettoso della frase di Puccini riferita al Tristano. Un intreccio tra Puccini e la sua esortazione di tornare a Wagner. Con quella scena finale dei due che si prendono per mano e svaniscono al buio come la musica che si decompone. Ma c’è anche Berio, forse un po’ troppo, perché si agitano echi e stili del suo linguaggio musicale. E qui ti chiedi cosa c’entri con Puccini e quella meravigliosa e colta opera che si chiude con la morte del musicista di Manon, di Bohème e di Tosca. È una domanda che mi son fatto solo io? Expò, vuoi vedere che tra anarchici e black bloc c’era anche Luciano Berio a contestare? Dissonanze e atonalità sono state captate nel rombo delle auto esplose e incendiate in via Magenta. Un altro enigma di Turandot?











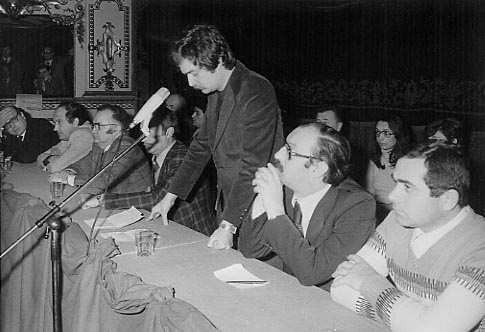

































































Leave your response!