Giovanna D’Arco trionfa alla Scala
Dire che si è messa in scena la Giovanna d’Arco di Verdi in onore della Francia colpita al cuore dal terrorismo islamico è fuori luogo. Si tratta di una singolare coincidenza. Anche perché, a ben pensarci, la pulzella d’Orleans combatteva gli inglesi invasori mentre oggi i britannici sono stati i primi a schierarsi al fianco dei francesi dopo il drammatico 13 novembre. Eppure già in passato si tendeva a dare significati artefatti ai temi dell’opera. Pensiamo al coro degli ebrei del Nabucco che veniva interpretato come un inno all’Unità d’Italia. Diciamo che il teatro d’opera ha in sé svariate magie e immaginare diversi significati, anche quelli meno rispettosi, non è mai vietato. Così questa Giovanna D’Arco di Verdi e Solera, davvero ai limiti del buon gusto il suo libretto, necessitavano di una lettura più logica. Come intendere quel padre parossistico che è preso oltre ogni misura dalla purezza della figlia e intende consegnarla al nemico per il solo sospetto che sia stata amante del re? E che poi si ravvede, crede alla figlia e viene subito perdonato. Anzi è lei che vuole essere benedetta da lui. Una trama ripresa dal dramma di Schiller che deforma la realtà. Qui Giovanna cade infatti in battaglia e non sul rogo degli inglesi, consegnata dai borgognoni. Ma tant’è, il melodramma è amore e morte, e anche guerra e passione. I registi Leiser e Caurier trovano una lettura più razionale, confinando nel sogno di una ragazza dell’Ottocento che si crede Giovanna d’Arco tutta la tortuosa e poco credibile trama. Eppure Verdi è sempre Verdi. E anche in quest’opera considerata minore, sopratutto per la mancanza di un afflato drammatico, anticipa molte della due successive creazioni. Solo un profano non s’accorge nel primo atto della presenza del tema del Dies irae della Messa da requiem, poi di frammenti del coro delle streghe del Macbeth, ma anche del preludio al coro del popolo disperato e tradito dal re, del Miserere del Trovatore, del dialogo tra Rigoletto e Gilda e di quello tra Violetta e Germont. Potremmo continuare a scoprire segmenti musicali che precedono il Verdi più maturo, perché Giovanna D’Arco, messa in scena per la prima volta alla Scala il 15 febbraio del 1845, che segue di un anno l’Ernani e di pochi mesi I due Foscari (correggo il critico del Corriere che colloca Giovanna dopo I Lombardi) è opera densa di trovate e di intuizioni. Anche se scarsa di impatto tragico, e questo differenzia il Verdi minore, quello degli anni di galera, quando il compositore bussetano sfornava opere a due o tre l’anno come in preda a un’ossessione da nevrosi compositoria, rispetto al Verdi più maturo, ma anche a quello di Nabucco ed Ernani. La sua ricerca, anche dopo frasi musicali che pare aprano al versante più radiosamente melodico, di motivetti e cabalette e valzerini rappresentano un freno al trasporto emotivo. Una ricerca di leggerezza e di orecchiabilità fuori luogo. Forse popolare per i tempi e proposti per ingraziarsi il pubblico. Certo non era facile musicare un libretto che contempla brani che sono al limite della banalità come “Quando agli anta l’ora canta, pur ti vanta di virtù”, che ben si potrebbe adattare a un coro degli invitati alla festa di compleanno di un neo quarantenne. Oppure quel “Appena Satàna si muove alla giostra, la femmina è nostra, la femmina è nostra”, che potrebbe essere trasferito pari pari in qualche cena arcoriana al ritmo di bunga bunga. Verdi è però inconfondibile e ci regala anche pagine di musica assolutamente apprezzabili come la sinfonia di preludio, come il duetto tra Giovanna e il padre, come quel finale, questo sì toccante, che mi ricorda tanto l’aria di Elvira dei Puritani “Ridatemi la speme o lasciatemi morir”. Il terzo e quart’atto sono densi di musica verdiana come il primo invece era segnato da quel motivetto che nell’Ottocento magari si cantava nei caffè “Tu sei bella, tu sei bella… “, richiamo infernale all’amor profano su Giovanna. Tormentone che viene ripetuto con sostegno orchestrare artefatto e che si scioglie sulla melodia. Merito della Scala aver dedicato il suo Sant’Ambrogio a questa memorabile produzione. Riccardo Chaily ha cercato nel timbro e nel ritmo della grande orchestra scaligera un significato all’uso predominante dei timpani, riuscendo a calibrare gli interventi, per altro non cospicui, che lo spartito presenta. Perfetta la coordinazione con il maestoso e sempre attento coro della Scala, coi cantanti, coi duetti e terzetti che si sviluppano nel corso dell’opera. Davvero meravigliosa e sfolgorante l’interpretazione di Giovanna da parte di Anna Netrebko, in un ruolo quando mai improbo che contempla registri acuti e rara potenza in quelli medio bassi. La Netrebko é oggi uno dei soprani più apprezzati del mondo, capace di trasferirsi da Mimì alla Leonora del Trovatore, solo leggermente calante nell’aria che conclude il second’atto. Il pubblico le ha decretato il più convinto trionfo. Convincente, per la sua capacità di fraseggio, di emissione e di estensione vocale il Carlo di Francesco Meli, forse il tenore lirico migliore tra quelli sul mercato italiano, oggi uno dei talenti più luminosi dell’intero teatro d’opera mondiale. Anche lui tenore lirico capace di sconfinare nel drammatico. E di portare a termine nel generale apprezzamento un ruolo una volta affidato a tenori di specialità, come Veriano Lucchetti. Devid Cecconi, il giovane baritono fiorentino che ha interpretato il padre di Giovanna, Giacomo, si è trovato improvvisamente a sostituire Carlos Alvarez, influenzato (che sia stato Renzi, presente nel palco reale, a farlo ammalare?) dopo la rigidità iniziale, quando scandiva il ritmo con il movimento delle spalle, si è via via sciolto dando il meglio di sé. Come uno studente consapevole di aver superato l’esame. Della regia si è già detto. Forse un po eccessivi quei mostri stile “La storia infinita” con orecchie alla Star Trek, e quella rassegna continua di crocifissi. Ma con l’aria che tira sfornare simboli di una religione non è poi neanche completamente fuori luogo.











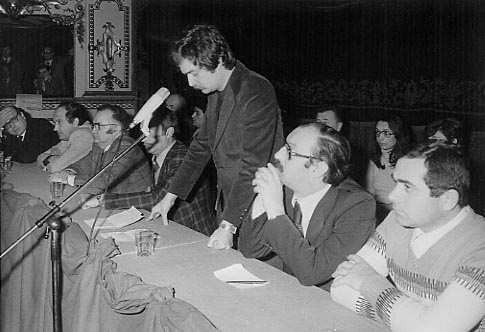

































































Leave your response!